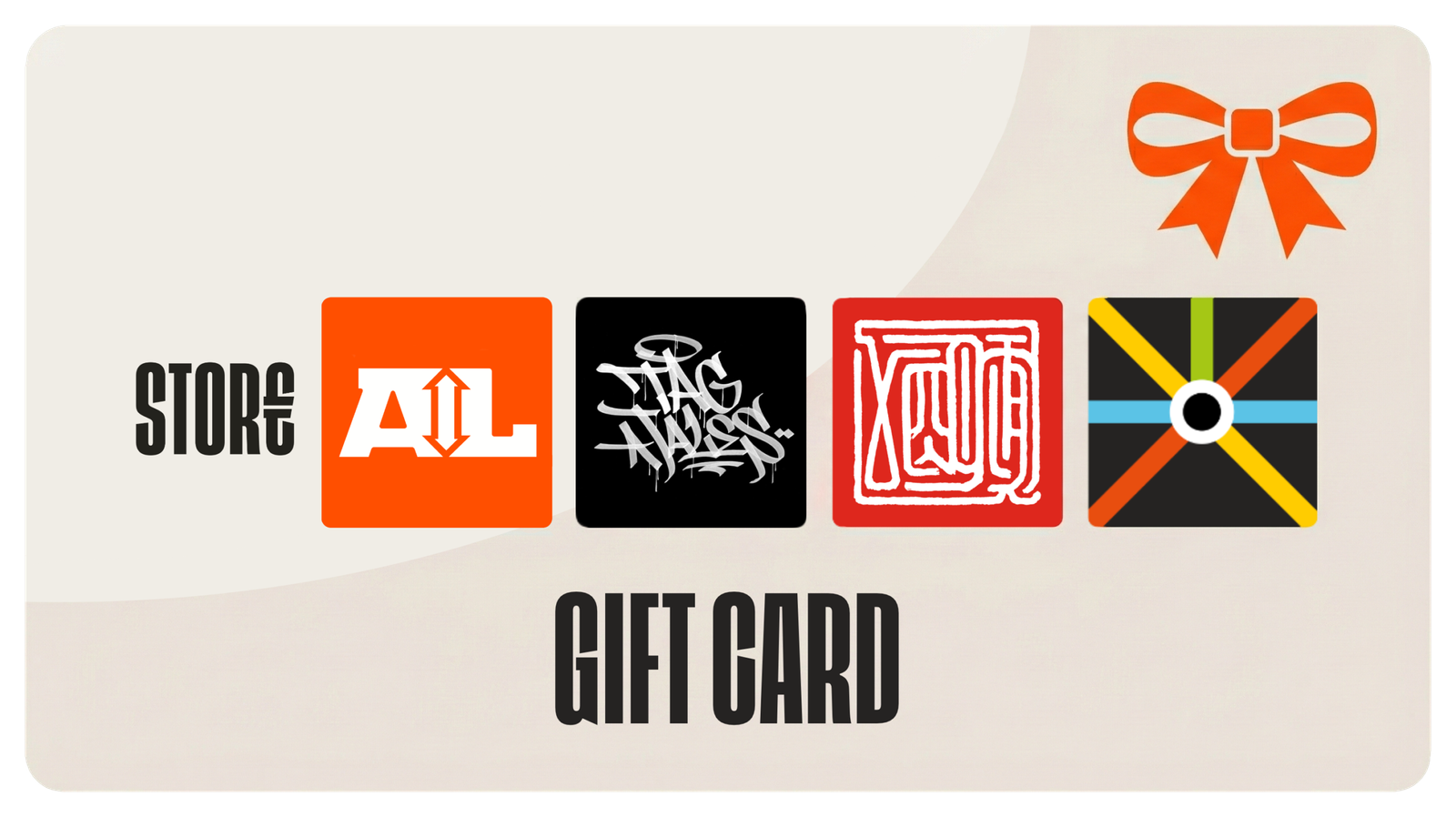DINASTIA DEI COSANG: UN RITORNO MATURO CHE SFIDA LA NOSTALGIA
Di Damir Ivic
È curioso che qualcuno sia rimasto deluso da “Dinastia”, il ritorno della ditta Cosang – Luchè e Ntò di nuovo uniti, qualche anno fa sembrava davvero impossibile – sulle scene, con del materiale nuovo. Curioso, sì. Perché la domanda che verrebbe da fare è: ma, cosa vi aspettavate esattamente? Davvero: cosa?
Se ci si aspettava un nuovo “Chi more pe’ mme” o una rinverdita “Vita bona”, beh, facciamo rispondere la matematica per noi: da questi album sono passati rispettivamente diciannove e quindici anni. Diciannove, e quindici. Voi che leggete: che persone eravate, vent’anni fa? Che gusti avevate? Che ascolti avevate? Come era fatta la vostra quotidianità? Quali erano le vostre priorità?
…ecco. Crediamo che questo sia un esercizio molto utile per capire veramente e, ancora di più, per apprezzare in senso lato e compiuto questo album. Un lavoro che è, prima di tutto, onesto. Sarà per minimizzare gli sforzi, sarà perché gli è venuto così, sarà perché sono troppo adulti e maturi per giocare a fare i ventenni fuori tempo massimo, sarà quel che sarà, ma sta di fatto Luchè e Ntò non hanno lavorato di cerone per fingersi ancora i malamente di una volta intrisi di cazzimma e di sguaiato, ruvido senso d’urgenza. No. Coerentemente con lo scorrere del tempo, e anche coerentemente col fatto che il rap in Italia ormai è una musica non più carbonara ma anzi ben conficcata nelle numeriche mainstream (anche per merito loro, in primis di Luché), “Dinastia” è un disco serenamente adulto e pacificato, nel suo essere urban e stradaiolo.
Il flow dei due fa sempre la sua porca figura (del resto, con la gente che c’è stata in giro negli ultimi anni è abbastanza dura non fare bella figura,no?, se arrivi da una scuola tosta come quella dei primi 2000). Gli argomenti e i ragionamenti sono più introspettivi, articolati, riflessivi, perdendo senz’altro quell’urticante capacità di fotografare con le parole gli spigoli, le cattiverie e le ombre ma guadagnando comunque in spessore. Chiaro: in questo modo è tutto meno incisivo, tutto meno cinematografico, tutto più da salotto o da live dove ti interessa più riprendere bene col telefonino la gente che canta che lanciarti in un mosh pit con degli (s)conosciuti. Ma questa è la vita.
È molto peggio essere dei signor Burns vestiti da skater, pensando di poter così ingannare qualcuno e lucrare al massimissimo sull’effetto-nostalgia della gente. Chi voleva i Cosang del 2005 o del 2009, o ne voleva almeno un credibile simulacro rifatti quasi in scala 1:1, era ed è più affezionato ai proprio ricordi andati che alla musica ed all’identità etico-artistica dei Cosang stessi. “Dinastia” è un disco senza picchi, senza meraviglie, senza abrasioni che resteranno nella storia; ma è confezionato molto bene. Le collaborazioni funzionano tutte (menzione d’onore per i Dogo che sembrano Marracash e Marracash che sembra i Dogo, così come per l’elegante traccia con Liberato che poteva essere un disastro dolciastro invece è stile ed eleganza), la delivery dei due titolari della ditta riuniti è appunto inappuntabile ed ammirabile (…ancora più “in controllo” e consapevole rispetto ai lavori che li hanno rivelati al mondo come Cosang), le idee musicali ci sono (alcune ottime, come “Non è mai fernut”: che stile) e non sono in generale mai sbrigative o dozzinali.
Che volere di più? Alla fine, è lo stesso ritorno che vi hanno e ci hanno dato i Dogo: godibile, appropriato, maturo. L’unica sfiga dei Cosang è che nel frattempo è arrivato Geolier a prendersi il ruolo di portabandiera, ruolo che a Milano nessuno ha conteso a Gué, Jake e Joe (Sfera troppo occupato a far soldi, Emis Killa troppo per tutti, Ernia troppo buono, Rkomi si è autoeliminato preferendo essere un Vasco 2.0 più che un rapper). Qui sta la differenza. Ma quello, onestamente, non è colpa di nessuno. E i Cosang possono sempre dire, a buon diritto, che nella “Dinastia” loro vengono prima. Quando era ben più difficile immaginare che una dinastia popolare e remunerativa potesse esserci davvero.
ASCOLTA “DINASTIA” SU SPOTIFY →
ISCRIVITI ALLA LISTA PRIORITARIA
Break boundaries

Break boundaries