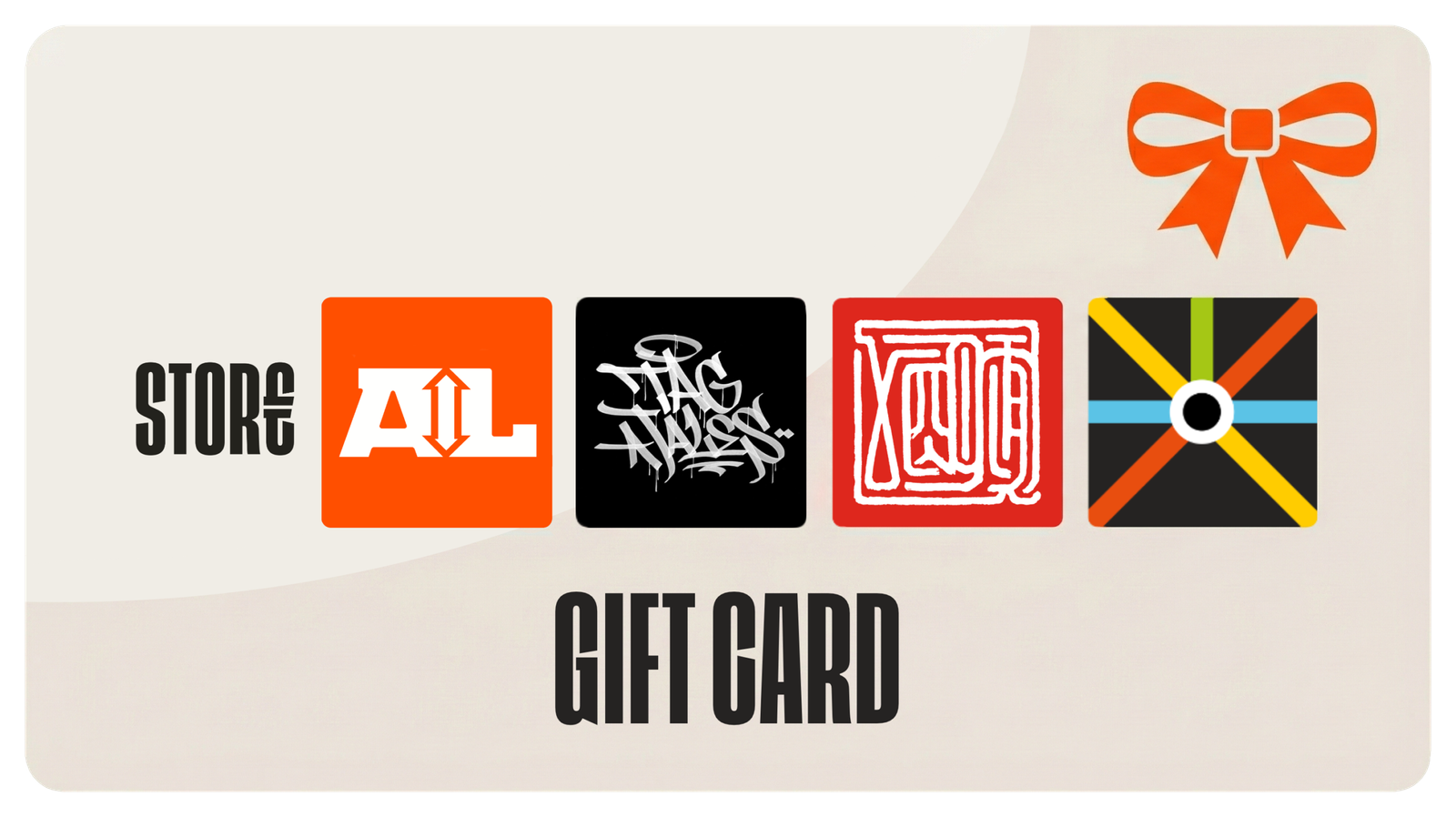BOUNCING IN NEW YORK

Luca Mich
Better go Soul
Una storia di musica e street-basket dai campetti della Grande Mela, nell’anno di Hip Hop 50.
C’è l’America, e poi c’è quella cosa lì, chiamata New York. Funziona anche se detta al contrario in realtà, perché nella Mela i background si incrociano, i rapporti di causa effetto pure, le storie piccole diventano grandi e quelle grandi non si ridimensionano mai, dilagano. Il tempo qui scorre in quattro quarti, c’è la batteria di qualche cassa che spinge dalle auto, c’è il beatbox di quel tipo all’angolo, c’è il pallone che rimbalza sull’asfalto e scandisce vite che si incrociano: chi quel playground lo controlla da anni, chi ci dorme sopra di notte, chi è qui in visita e vuole provarci, a sfidarsi, chi ne ha sentito parlare di quello che respiri mentre con un occhio guardi la borsa appoggiata sulla panchina dietro al canestro, con il collo fai la finta di andare da un lato e con la mano, beh, con quella fai un crossover e incroci le strada di persone anni luce distanti da te, eppure uguali, su quel rettangolo.
In quel momento lì il tempo si ferma, sei a New York, e stai tirando. E vai a chiederlo a qualche bot che cos’è quella città in quel momento. Vagli a chiedere il sudore, vagli a chiedere gli spintoni, vagli a chiedere il “good D bro, now just pass me the damn ball”. Chiedigli perché certe cose accadono solo lì, a quel che provi quando attraversi sulle strisce palleggiando, a quello che senti mentre esci da te stesso e incontri il mondo che avevi immaginato, che avevi letto, quello su cui hai visto mille film, quello che ti appartiene senza sapere perché, quello a cui dai forma nella tua mente, di solito. Chiedigli dei tuoi glitch mentali, di Starks in volo sopra Michael su al Madison, di Starbury e della ruota di Coney, di Drazen che stringe Kenny Anderson, di Willis che alza il braccio ed Earl che appoggia le monete in cima al tabellone. Chiedigli cosa si prova quando vivi per davvero quel che hai in testa. Quel che ti è arrivato per immagini, a pezzettini, e che poi hai unito in un flusso organico di sogni e pensieri. Per raccontare quella città devi averci respirato su quell’asfalto ad agosto, devi averlo rincorso per tutto il campo quel tipo che ti stoppava su a The Goat, dove Bobbito ti raccontava di quella prima volta tra Nas e Jay Z da lui in radio, prima di commentare il tuo palleggio col megafono, come in NBA Street.
Glitch, che diventano realtà, quando sei lì. Perché l’odore dei bagel bruciacchiati sulla piastra l’AI non te lo racconta. Che poi tu di AI ne conosci uno solo e fa rima con Iverson, che di New York non è, ma l’attitude è quella lì e ti è arrivata anche a kilometri di distanza, oltre oceano, dentro ai tuoi mondi. Ce l’hanno trasmessa le immagini con cui al di qua dell’Oceano ci nutriamo fin da quando i supporti erano cartacei, o le gesta di qualche leggenda, le recuperavi su nastro magnetico. Quando di quel che accadeva nelle strade te lo raccontava Pete Axthelm in The City Game che era puro culto per chi si nutriva di asfalto anzichè di parquet. Quella New York lì è marchiata a fuoco in chi l’ha immaginata più forte degli altri, sfogliando pagine e consumando il tasto del rewind sul registratore, quello che dopo un po’ al posto delle due freccette lasciava spazio ad un vuoto proporzionale a quanto quei video ti avevano riempito occhi ed anima.
Che tu sia cresciuto con il mito NBA, con quello dello streetball o con la semplice voglia di saperne di più del Gioco, le strade dei 5 quartieri in qualche modo le hai percorse prima di arrivarci. C’è l’asfalto e c’è il legno del Madison, ci sono le paludi delle meadowlands e la maglia ritirata di Doctor J che penzolava nello Stato Giardino e ora affianca la 72 in onore di Notorius BIG giù a Brooklyn. Ci sono i crossover di Marbury e Crawford sullo stesso parquet e i voli di Vince Carter in maglia Nets, ci sono le grandinate di punti che tutti quelli che passano di qui regalano ai Knickerbockers e ai tifosi che per lo più sono turisti e portano a casa qualcosa di più che nelle altre città. Qui si riscrivono i record, sul palcoscenico di The World Most Famous Arena, sorry Knicks. In tutto questo immaginario ci sono i Knicks dei titoli che ti hanno raccontato ma che nessuno in Europa pare aver davvero visto, e ci sono anche quelli targati anni ‘90 delle risse al Garden, di Patrick Ewing, Anthony Mason, Charles Oakley, quelli dei titoli del New York Post che ti leggevi in metro con la stessa voracità con cui Joey Chesnut (dal 2007 ad oggi 16 volte campione della leggendaria “Hot dog Eating Challenge”) sbarana i panini di Nathan’s a fianco della Wonder Wheel giù a Coney Island.
Ogni tanto le facce di quelle leggende spuntano sui muri delle wall of fame della Bushwich Collective, in un corto-circuito di icone che partono da Manhattan e attraversano il Brooklyn Bridge grazie alle bombolette spray di uno dei collettivi più produttivi e creativi del quartiere più popoloso della mela.


E su ad Harlem invece? Cammini e Gordon Parks è lì con te, non sei in una sua foto coi bambini che giocano con gli idranti d’estate, è proprio lì con te a darti quell’immagine. Prosegui, passi le bancarelle della 125esima con i profumi e gli incensi e ad un “love that t-shirt, love ODB, love WuTang Shit” ti permetti di rispondere “love your hair madam, Tina Turner like” e si generano sorrisi. Scendi dalla metro e sei nel tuo luogo di energia, West 4th Street. Davanti a The Cage ti fermi a osservare il mondo che sfila da Joe’s Pizza e ti commuovi addentando una Sicilian.

Common al Hip Hop 50 Live, mega concerto per i 50 anni dell’Hip Hop che si è tenuto l’11 agosto 2023 allo Yankee Stadium nel Bronx, New York City.
È l’estate di HIP HOP 50, lo spirito dei primi anni della nostra cultura è tornato e c’è musica ovunque. Tempo di South Bronx, il mega concerto con le leggende della new ed old school organizzato da Nas e Mass Appeal sta per accadere…e mentre Common mi sputa in faccia penso che non possa essere vero che ci sia un clima così rilassato pieno di sessantenni attorno a me che conoscono ogni singola parola di tutti i pezzi. I giovani ci sono, Wu Tang is for the Children, la cultura si espande e super generazioni. Lo ricordo pure Methodman che appare a sorpresa sul palco assieme a Ghostface. È una serata incredibile, un tributo ai 4 quarti che avvolgono una città e che l’hanno messa sulla mappa mondiale della street culture.

Il giorno dopo alter jam: “This is real Hip Hop shit, this is for the people, fuck Yankee Stadium”. Dice KRS ONE Sedgwick Avenue, culla dell’Hip Hop culture dove il giorno dopo il mega evento Hip Hop 50, va in scena una jam di dimensioni colossali: il quartiere è in strada, migliaia di persone in festa, le signore 70 enni hanno preso posto davanti alle transenne già da ore con i loro seggiolini portatili, c’è chi vende “ice cold water”, chi stampa magliette con la scritta Hip Hop che tanto oggi si vende, chi breakka chi dipinge, chi sale sul palco a scaldare in attesa di KRS, Fat Joe, Chuck D. È il quarto block party in città, il più atteso, quello del South Bronx. E mentre il giorno dopo ad Harlem, davanti all’Apollo, il clima è di totale festa, mood funky e rilassatezza, l’aria dura del Bronx si respira dalle facce di chi ha visto di tutto, di chi è lì in attesa di incendiarsi, no jokes. E se ad Harlem ballano sulle selecte di Red Alert, qui nel Bronx nessuno muove una falange e rimane serio fino a che non sale Fat Joe coi suoi suoni tamarri. La folla si riscalda e quando a Chuck D si unisce Flavor Flav ne esce una jam con i Public Enemy e tutto pare prendere fuoco. La gente salta, urla, inizia a spingere. Penso che se c’è un posto dove tutto può degenerare è quello: è il fottuto Bronx ya know?! KRS capisce e a calma gli animi con discorsi conscious e sorrisi.

Ad Harlem invece la presa bene è generale, il pubblico balla e c’è pure Yussef Salaam dei Central Park 5 (docu su Netflix imperdibile) che ha fatto chiudere la strada per l’evento. Le differenze tra quartieri si sentono, ti aiutano a capire anche dove nascono le diverse sfumature del rap newyorkese. Non lo avevo mai realizzato prima. L’essenza del hiphop50 è nelle facce delle persone, nei pezzi cantati da giovani ed anziani che mi ricordano quanta strada ha fatto il genere che qui non è roba da appassionato ma il vissuto vero di tante persone che celebrano nomi che che qua sono leggende ed al di fuori sono poco più che meteore. Sale Black Sheep e la folla impazzisce: “He is my age man”, grida un vispo nonno con nipote in braccio. Mi porto il pugno al cuore, lo guardo, ci capiamo, è l’ Hip Hop che ci unisce, le epoche, gli stili, tutto si fonde in un abbraccio alla cultura, quella che prosegue nelle strade, nei playground…

Di New York conosci pure lo stile di gioco in qualche modo, te lo ha insegnato Mark Jackson nei 90: zero tiro da tre, penetrazioni dal palleggio una dietro l’altra e scarico all’ultimo solo in caso di passaggi a livello in vista. È quello stile che ritrovi nei playground, quando pensi di impostare l’attacco e ti accorgi che nessuno si aspetta realmente un passaggio: sta a te giocarti l’uno contro uno, hai quell’occasione lì, giocatela fino in fondo, se va bene ne avrai un’altra, se va male la prossima palla la rivedi a fine match, quando ti levi dal rettangolo e la consegni a quelli che giocano dopo di te. Questa cosa qui negli anni ha generato decine di players che partivano proprio dai playground, da The Cage, Soul in the Hole, Park Slope, Rucker Park e decine di altri e si riversavano nella “League” o in certi casi anche in Europa. Chiedere a Kevin Punter o Dustin Hogue per esempio, ultimi baluardi “nostrani” di quel tipo di basket made in The Bronx che possiamo ancora ammirare sui nostri campi e poi… poi chissà quando ci ricapiterà perchè da NYC oggi escono sempre meno giocatori iconici, e il Bronx non fa eccezione nel calo della produttività.
Quei giocatori lì sono strasichi della Boogie Down Production, come KRS One, il maestro di cerimonia che dalle strade di “6” (la metro verde che arriva fin quassù e che aggiunge un nickname al quartiere che ha dato i natali alla cultura della doppia H) il suono del South Bronx l’ha portato in tutto il mondo e continua a sostenerlo, ora che la fanno da padrone quelli di LA ed Atlanta. E se ne rendono conto i “the originators”, i custodi di questa cultura che sia dello spalding su cemento o del microfono su un palco: KRS nell’anno delle celebrazioni per i 50 dell’Hip Hop ha organizzato una jam vecchio stile in ognuno dei 5 quartieri per ribadire chi ha messo questa cultura sulla mappa mondiale, Bobbito Garcia dal canto suo continua a produrre documentari per raccontare come basket e new york culture si contaminano da sempre (il suo docu “Do it in the Park” è secondo solo al suo libro “Where did you get those?” per venerazione da parte di chi ama la street culture, lo sneaker game e le contaminazioni tra fashion e cultura urbana). Cambiano le geografie, le mode e le tendenze, ma chi ha generato qualcosa per primo, quelle rose cresciute dall’asfalto, meritano un posto speciale nella storia. E quel posto, tanto nel basket quanto nell’Hip Hop, si chiama New York, New York: “a state so nice that you have to name it twice”. C’è energia nelle strade dei quartieri di New York, ti fa pensare che tutto sia possibile, che ognuno è arrivato qui per un motivo, ha a che fare con l’esprimersi, il cercare, e in certi casi per i più fortunati, con il trovare. C’è energia e c’è casino, ci sono stimoli, c’è cemento e asfalto, ci sono facce dure e eghi da affermare, pance da sfamare, lo respiri in strada e lo tocchi con mano nei campetti: c’è urgenza di esserci, oggi, subito, in ogni azione. Non c’è tempo di costruire l’attacco, c’è l’uno contro uno, io contro te e chi segna, regna. New York è tutta qui: è alleare le skills per sfidarti adesso. “There is now tomorrow”: la quintessenza del qui ed ora.

Luca Mich
E a pensarci bene, a proposito di urgenza, di strada e di immaginari generati da NYC, senza bisogno dell’AI, l’Hip Hop non poteva nascere che qui. E se le strade ne hanno codificato le quattro discipline, (writing, breaking, mciing, djing), il cuoio e l’asfalto ne hanno forgiata un’altra a suon di swoosh, clap, swing e suole sull’asfalto. Gli scratch OG, original sound of Manhattan. È sempre questione di quella cosa lì: esprimersi, farlo in strada, dal basso, in mezzo alla gente, in mezzo a chi è come te, da qualsiasi luogo provenga, qualsiasi fuso abbia in corpo. Simili che risuonano su quel beat, quello che va a tempo col palleggio, che fa vibrare il cuore e tenere ferma la mano, mentre spezzi il polso. E allora quando mi chiederai che cos’è New York, ti risponderò che è una città che batte in quattro quarti. È un playground enorme in cui si incrociano culture in modo solo apparentemente casuale, ognuno è lì per fare il suo gioco, lasciare su quell’asfalto e tra quei palazzi tutto ciò che ha, le sue skills migliori, le sue passioni e le propensioni, per sfidare se stesso e gli altri in un pick-up game di culture, per dare forma a ciò che prima di arrivare qui, aveva soltanto immaginato.
Tutto qui rimbalza ad una precisa frequenza. È il pulsare di questa città, il suo battito in quattro quarti su cui puoi batterti o tenere il tempo. In ogni caso il suo ritmo ti entra dentro. Ecco perchè New York è pallacanestro. Ecco perché è Hip Hop. Ed ecco perché il basket, il baloncesto, el basquet, il koŝarka, el basquetebol, The Game, el juego, alla fine non è mai solo pallacanestro, è Hip Hop culture.
ISCRIVITI ALLA LISTA PRIORITARIA
Break boundaries

Break boundaries